Integriamo in questa rubrica del nostro periodico ben tre schede divulgative e celebrative dedotte (con autorizzazione del suo direttore, Mauro Del Bue) dalla consorella testata prampoliniana La Giustizia. Si tratta di un'importante rivisitazione di personaggi e vicende, più o meno lontane nel tempo,che appartengono alla storia sia del socialismo italiano che, più in generale, dell'Italia. Nel ringraziare La Giustizia e gli autori,tra l'altro nella certezza che questa partnership editoriale di “militanze” molto contigue allargherà il raggio della visibilità, preannunciamo (anche se da tempo si comprende la nostra fedeltà al core business sia della testata che della nostra testimonianza politica), a beneficio di lettori principalmente interessati all'approfondimento ed alla divulgazione della storia e della cultura politica, il prosieguo e l'implementazione di questa rubrica. Peraltro, evidenziamo la parte in causa (territoriale) di due dei personaggi, oggetto dei saggi. Bianca Bianchi, eletta nell'Assemblea Costituente, ebbe trascorsi docenti a Cremona e Giuliana Nenni ebbe, ce lo ricordavano i nostri “vecchi”, numerosi contatti con il PSI nelle Circoscrizione Mantova Cremona. Ultimo ma non ultimo (per importanza) l'importante ritratto di Angelina Merlin, ben noto ai “nostalgici” di decenni addietro, ma risucchiato nell'oblio. Ritratto di Merlin, che, inspiegabilmente, già “in corso d'opera” veniva in certo qual modo periferizzato dal ritratto della famiglia socialista. Inspiegabilmente e ingiustamente. La sua militanza e soprattutto la sua legge sono attuali. Al punto che nella BRD si sta allestendo una legge che ricalca (mutatis mutandis) la Legge Merlin.
********
 LUCIA ABBATANTUONO*
LUCIA ABBATANTUONO*

Bianca Bianchi, la leonessa fiorentina
Leonessa, e non solo per astrologici natali, Bianca Bianchi lo è stata davvero. Una grandiosa madre costituente, e non solo perché pedagogista e filosofa. Fiorentina, classe 1914, figlia di un fabbro di Vicchio, gran lavoratore e attivo socialista. Rimasta presto orfana, sarà allevata dalla famiglia materna a Rufina e poi proseguirà gli studi nel capoluogo mediceo. Si laurea alla facoltà di magistero nel 1939, mentre Hitler sale al cancellierato. Il suo primo incarico da insegnante (di filosofia) fu a Genova, esattamente a Bolzaneto, poi a Cremona. Bianca incontrò presto difficoltà e ostacoli con i presidi delle scuole in cui insegnava, e finì col perdere il lavoro proprio per le troppe divergenze coi suoi superiori: questi ritenevano che le sue lezioni fossero condotte in modo “troppo indipendente”. Ad esempio, Bianca non volle mai ignorare la cultura e la civiltà ebraica, escluse invece dal programma didattico di Stato fascista.
Rimasta disoccupata, per sopravvivere sia al secolo che spiritualmente, nel 1941 Bianca accettò con slancio la proposta di incarico come insegnante di lingua italiana in Bulgaria. Rientrò poco dopo, nell'estate del '42, restando a Rufina fino alla caduta di Mussolini. Appena le condizioni liberate della nazione lo consentono, torna a Firenze e partecipa alle riunioni del Partito d'Azione. Prende parte al volantinaggio antifascista e, proprio come Oriana Fallaci, si cimenta nel trasporto di armi a sostegno dei partigiani toscani arroccati nelle campagne.
Nel 1945 si iscrive allo PSIUP di Saragat e Nenni, e collabora a diversi giornali politici (tra i quali anche La Giustizia). Alle elezioni del 2 giugno 1946 Bianca è eletta all'Assemblea Costituente: è una delle sole 21 donne su 556 membri totali. Durante lo spoglio delle schede, fu proprio lei la prima donna a risultare eletta. Va sottolineato che i suoi consensi furono più del doppio di quelli raccolti dal capolista Sandro Pertini. Il suo operato nella Costituente la vide impegnarsi soprattutto nella scuola, nelle pensioni e nell'occupazione. A gennaio del '47 segue il gruppo di Saragat nella celebre scissione di Palazzo Barberini, quella che fondò il nuovo partito socialdemocratico (prima PSLI, poi PSDI). Nel 1948 il suo intervento al Congresso Internazionale delle Donne ad Amsterdam suscitò emozione e scalpore quando comunicò a una platea attenta e stupita che in Italia sui documenti dei figli naturali e persino sulle pagelle scolastiche veniva apposta la dicitura “figlio di NN“. Candidata in Sicilia nel medesimo anno, è eletta nella I legislatura per la lista di Unità Socialista. Nel 1949 presenta la prima di una serie di proposte di legge sul tema della tutela giuridica dei figli naturali. Bianca voleva rendere più attuabile il riconoscimento della paternità, ed estendere le eccezioni al divieto di ricerca. Il suo progetto legislativo incontrò molte resistenze, ma alla fine sarà approvato nel 1953. Con molte battute d'arresto e molte esitazioni, va ricordato che solo nel 1955 la dicitura “figlio di NN” fu eliminata dai documenti anagrafici, ma per giungere alla parificazione dei diritti tra figli naturali e figli legittimi si dovranno poi attendere quasi 60 anni, con un lungo e sofferto cammino concluso solo nel 2012. Poco dopo interrompe la sua esperienza politica per dedicarsi completamente allo studio dei temi dell'educazione. Pubblica i Lineamenti di Metodologia, un testo che affronta questioni fondamentali per la formazione del bambino: “Quali sono i bisogni psicologici del bambino? Quali le leggi del suo sviluppo fisiopsichico? Come debbono essere i programmi ed i metodi scolastici, per ispirarsi a questi principi?“ Si impegna molto anche nella contestuale creazione di un istituto modello per ragazzi della scuola elementare e media. Fondata nel 1958, questa “Scuola d'Europa“ sorge alle pendici del preappennino toscano a oltre 700 metri di altezza, immersa nel verde dei boschi che circondano il Monastero di Montesenario a 15 km da Firenze. Si trattava di un progetto lungimirante, sperimentale, e di certo all'avanguardia, di cui scrisse nei suoi saggi “Amicizia per i nostri figli” e “L'esperienza di un'educazione nuova“. Furono, quelli, gli stessi anni che la videro molto attiva nella redazione de “La Nazione” di Firenze, di cui curo' la rubrica “Occhio ai ragazzi”, tutta dedicata ai problemi educativi.Dal '70 al '75 fu vicesindaco di Firenze, eletta nelle liste del PSDI. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò soprattutto alla scrittura, specie con opere autobiografiche. È morta a Firenze nel luglio di 25 anni fa. Tratto da Vivrò ancora (Firenze, 1997) ricordiamo uno dei suoi più struggenti pensieri, di quelli che a fine vita incorniciano decenni di strenue lotta politica: “La solitudine è una grande amica: non urla, non minaccia, non ricatta, non condiziona, non ruba, non uccide“. Grazie, Bianca.
^^^^^^^^^^^
Giuliana Nenni, l'estensione di Pietro LUCIA ABBATANTUONO*
Potremmo romanticamente definirla “un regalo di Natale”, Giuliana Nenni, considerando che nacque a Faenza il 26 dicembre del 1911. Potremmo, se non fosse che la madre la diede alla luce mentre il padre era in carcere per le sue proteste contro la guerra italo-turca. Delle quattro figlie di Pietro Nenni, Giuliana fu di certo la più volitiva. Nel 1926, quando tutta la famiglia si trasferì a Parigi, e Nenni diventò segretario del Partito Socialista Italiano e direttore del Nuovo Avanti, Giuliana frequentò alla Sorbona i corsi di Civilisation francaise. Al contempo si dedicò al giornalismo e diventò presto redattrice del giornale socialista Populaire. Aderì al PSI nel 1934 e svolse attività politica nella sede parigina dell'Unione Popolare Italiana.
Due anni dopo fu proclamata segretaria del Comitato di lotta antifascista. Appena scoppiata la Seconda guerra mondiale la famiglia Nenni fu confinata a Saint-Flors, a causa delle persecuzioni fasciste. Da lì Giuliana riuscì comunque a mantenere stretti rapporti con le forze antinaziste francesi.
Caduto Mussolini, rientrò subito in Italia e curò nella capitale i rapporti tra i socialisti e il CLN centrale. Furono gli anni in cui Giuliana partecipò attivamente alla resistenza, costituendo un piccolo comitato con Adele Bei Ciufoli, le sorelle Ribet, Adele Maria Jemolo, Maria Fermi, Linda Puccini e altre: il comitato aiutava i prigionieri in fuga, e organizzava manifestazioni, distribuendo stampa e manifesti.
Nel dopoguerra si dette a promuovere l'UDI (Unione Donne Italiane) con Rita Montagnana, Rosetta Longo e Marisa Conciari Rodano. Fu a lungo membro sia della Commissione femminile centrale del PSI che della segreteria dell'UDI. Nel 1948 Giuliana Nenni fu eletta alla Camera dei deputati per la circoscrizione Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì nelle liste del Fronte Democratico Popolare, e si iscrisse al gruppo parlamentare socialista.
Alla Camera proseguì la collaborazione con le altre parlamentari provenienti dall'Unione Donne, presentando una serie di proposte di legge aventi ad oggetto l'emancipazione della donna, in particolare nel mondo del lavoro.
Fu rieletta nel 1953 e divenne componente sia della V Commissione (Difesa) che dell'Ufficio di Presidenza, fino al giugno del '58.
Compiute due legislature da deputata, fu eletta al Senato nel 1958 prima e nel 1963 dopo.
Di Giuliana Nenni va ricordato che è stata la prima parlamentare a proporre una legge sul divorzio. Il suo progetto sosteneva in Senato il disegno di legge del compagno di partito Luigi Renato Sansone sul cosiddetto piccolo divorzio, applicabile solo ai matrimoni con scomparsi senza lasciare traccia, condannati a lunghe pene detentive, coniuge straniero in presenza di divorzio all'estero, malati di mente, lunghe separazioni fra i coniugi o tentato omicidio del coniuge.
Fu anche firmataria, insieme a Carlo Venegoni e Teresa Noce, della legge n. 394/1951: “Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri“. E firmò anche la legge n. 35/1952: “Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari“, insieme a Giuseppe Di Vittorio, Fernando Santi e Gisella Della Portella.
Fu inoltre tra i firmatari della legge di abrogazione della normativa elettorale maggioritaria del 1953 (la cosiddetta “legge truffa”), insieme a tutti i maggiori esponenti del Partito Socialista (Pietro Nenni, Sandro Pertini, Riccardo Lombardi, Lelio Basso e altri).
Altre sue proposte di legge sulle pari opportunità e il diritto di famiglia, non approvate all'epoca perché troppo avanzate, sono state oggetto di grandi battaglie civili nei decenni successivi (tutela della maternità; tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio; modificazione delle norme del Codice civile attinenti alla patria potestà; parità dei diritti e delle retribuzioni per un pari lavoro, solo per citarne qualcuna). Al termine del secondo incarico da senatrice, Giuliana si ritirò dagli impegni istituzionali e si dedicò completamente al padre facendogli da segretaria. È stata lei a curare il riordino delle carte di Nenni e la pubblicazione delle pagine del suo Diario, e non solo di quello.
La passione per la politica e per il socialismo ha accompagnato Giuliana Nenni anche nei suoi ultimi anni di vita, come dimostrano i suoi frequenti contatti con Boselli, Amato e Vassalli. Ci ha lasciati novantenne, nel 2002. Ma ci ha lasciato anche tutti i principali scritti di Pietro Nenni. Sono stati, infatti, scritti da lei, ma con le carte del padre, alcuni tra i più fondamentali saggi della polizia italiana, (tutti a firma Pietro Nenni); Sei anni di guerra civile (con lo pseudonimo di Giuliana Emiliani), nel 1945;
Tempo di guerra fredda: Diari 1943-1956, nel 1981; Gli anni del centro-sinistra: Diari 1957-1966 nel 1982; I conti con la storia: Diari 1967-1971, nel 1983.
Quando le chiesero quale fosse la maggiore preoccupazione di Pietro Nenni prima di morire, Giuliana rispose: “Lo strapotere dei partiti che stanno minacciando la fragile democrazia e la Costituzione del nostro paese”. Era il 1980. Nulla è cambiato.
E quando a Giuliana fu chiesto di svelare quale fosse la ricetta del padre per una buona politica, non ebbe dubbi e rispose: “L'uomo giusto nel posto giusto, era la massima di papà. Era sempre pronto a riconoscere che un uomo capace, democristiano o comunista, fosse meglio di un socialista incapace. E viceversa”. Era il 1980. Non solo nulla è cambiato, ma peggio: di persone come Pietro e Giuliana Nenni ne mancano. Troppo.
^^^^^^^^^^^
Storia socialista

Lina l'indomita di LUCIA ABBATANTUONO*
«Sono stata coerente con la mia decisione, non ho accolto inviti né da sinistra né da destra, ho rifiutato interviste che avrebbero dato a un fatto serio e doloroso l'aspetto del pettegolezzo, dal quale rifuggo, e di una meschina vendetta derivante da un astio che non sento».sì disse Lina Merlin strappando la tessera del PSI. Le sue parole furono raccolte nel 1989 dalla sua amica scrittrice Elena Marinucci, autrice dell'unica autobiografia ufficiale della grande socialista madre della Costituente. Parliamo di Angelina Merlin, prima donna assoluta eletta al Senato della Repubblica. Padovana (crebbe a Chioggia) si trasferì a Grenoble e lì si laureò in letteratura francese. Da giovane maestra Lina noto' subito le drammatiche condizioni in cui vivevano le donne del suo tempo: in particolare, non tollerava l'ipocrisia dei capi famiglia religiosi e osservanti, che nonostante i loro principi frequentavano comunque le prostitute. Le case chiuse erano considerate uno svago per i giovani maschi, mentre per una donna era scandaloso avere rapporti sessuali fuori del matrimonio.
Anche per questo si avvicinò agli ideali del socialismo, che riteneva vicini alla sua mentalità e alla sua morale. Si iscrisse perciò al Partito Socialista Italiano, cominciando a collaborare al periodico La difesa delle lavoratrici, di cui diventerà direttrice. Collaborò con Giacomo Matteotti, cui riferiva tutte le violenze perpetrate dalle squadre fasciste nel padovano. Dopo l'assassinio del suo mentore, in due anni subi' cinque arresti. Nel 1926 fu anche licenziata perché si rifiutò di giurare fedeltà al regime, cosa obbligatoria per gli impiegati pubblici.
Dopo la scoperta del complotto Zaniboni, il suo nome fu iscritto nell'elenco dei “sovversivi” affisso nelle vie di Padova. Lina quindi si trasferì a Milano e collaborò con Filippo Turati, fino al nuovo arresto e ai cinque anni di confino in Sardegna. Tornata a Milano nel 1930, incontrò il medico ed ex deputato socialista Dante Gallani e lo sposò nel 1932. Purtroppo Lina rimase presto vedova, a 49 anni. Si dedicò quindi completamente alla Resistenza, donando ai partigiani la strumentazione medica e i libri del marito, e raccogliendo fondi e vestiario per i partigiani.
Prese anche parte ad azioni di guerra partigiana, rischiando più volte la vita. Catturata dai nazisti, fuggì con uno stratagemma. Scrisse articoli sul periodico socialista clandestino Avanti!, e fu nella sua casa di via Catalani 63 che Lelio Basso, Sandro Pertini, Rodolfo Morandi e Claudia Maffioli organizzarono l'insurrezione. Col professor Giorgio Cabibbe e i partigiani della Brigata Rosselli occupò il Provveditorato agli Studi di Milano, imponendo la resa. Il 27 aprile 1945 il CLNAI la nominò Commissario per l'Istruzione di tutta la Lombardia. Finita la guerra, Lina si stabilì a Roma alla direzione nazionale del PSI. Nel 1946 fu eletta all'Assemblea Costituente, e il 18 aprile del 1948 al Senato della Repubblica.
I suoi interventi nel dibattito costituzionale, come membro della “Commissione dei 75”, furono determinanti per la tutela dei diritti delle donne, e lasciarono un segno indelebile nella Carta Costituzionale. A lei si devono infatti le parole dell'articolo 3: “Tutti i cittadini…sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso”. Uno dei punti cardine, se non il principale, dell'opera politica di Lina Merlin fu la battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia, seguendo l'esempio dell'attivista francese Marthe Richard, che già nel 1946 aveva fatto chiudere le case di tolleranza in Francia. La legge Merlin fu approvata dopo 10 anni di dibattito, il 20 febbraio 1958. L'iter della legge che porta il suo nome fu lento e costellato d'ostruzionismo, di destra e di sinistra, di parte laica e di parte cattolica. “Oggi, in linea di diritto, esiste l'uguaglianza dei due sessi, ma la frattura sussiste sul terreno della realtà. Il processo storico in atto sarà completato quando, risolto il travaglio della questione sociale, la donna acquisterà, in una civiltà nuova, una personalità nuova, liberata dal giogo entro cui l'aveva costretta una concezione semplicistica dell'alta funzione della maternità”.
Nelle sue battaglie mostrò tutta la sua tenacia, e seppe ribattere in maniera efficace e tagliente alle battute, spesso poco cavalleresche, che le rivolgevano i colleghi nei corridoi di Palazzo Madama. A lei si devono anche l'abolizione del nomen nescio che veniva apposto sugli atti anagrafici dei trovatelli, l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi in materia fiscale, la legge che eliminava le disparità tra figli adottivi e figli propri, e la soppressione definitiva della cosiddetta “clausola di nubilato” nei contratti di lavoro, che imponeva il licenziamento alle lavoratrici che si sposavano.
Era tenace, odiava la proprietà privata, lo sfruttamento “dell'uomo sull'uomo” e le “signore borghesi”. Aveva a cuore l'emancipazione delle donne oppresse. Era rispettata, brava a parlare e a convincere. E non si perdeva in fronzoli. Eppure nel 1961 il partito non volle ripresentare la sua candidatura nel collegio di Rovigo, dov'era già stata rieletta al Senato nel 1953 e alla Camera dei deputati nel 1958. Lina reagì strappando la tessera. Nel discorso di commiato dichiarò che le idee sono sì importanti, ma camminano con i piedi degli uomini, e che lei non ne poteva più di «fascisti rilegittimati, analfabeti politici e servitorelli dello stalinismo».
A nome di tutte le Donne: grazie, Lina.
*
LUCIA ABBATANTUONO - Vice Direttrice. Giornalista pubblicista. Laurea cum laude in Scienze Politiche Economico/Internazionali. Master ISSMI - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. Prima stagista UNESCO e ricercatrice per i Ministeri dell'Interno e della Difesa, poi analista al Centro Alti Studi per la Difesa. Esperta di politica militare e diritto internazionale. Oggi funzionario pubblico. Appassionata di letteratura, musica classica e studi classici, è pianista per diletto. Ha pubblicato un romanzo e diverse antologie poetiche. Autrice per L'Avanti! di Mauro Del Bue fino al 2023, oggi scrive anche per le riviste Il Chaos, La Lettera 22, Mondo Operaio e L'Autiere. Moderatrice e relatrice in dibattiti accademici sul diritto internazionale. Socia del Club di Cultura Classica e dell'Associazione Socialista Liberale. Aderente a Reporters sans frontières e al Movimento Federalista Europeo.
////////////
 In evidenza
In evidenza
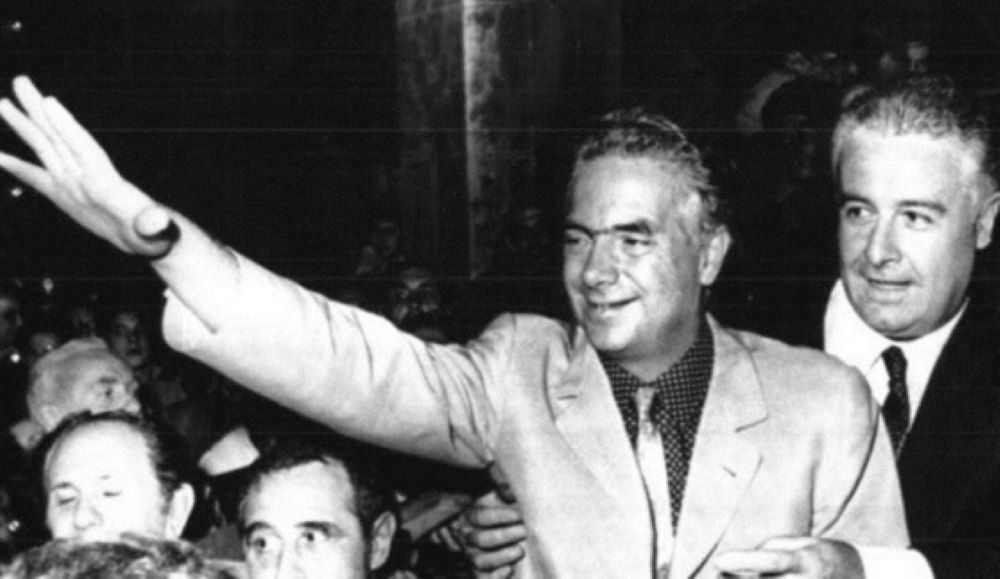
Dalla legge sul Divorzio alla legge sul “Nuovo diritto di famiglia” approvato 50 anni orsono. di Giovanni Crema *
L' Italia conquista la Legge sul divorzio il giorno 1 Dicembre 1970. Proprio in questa data, infatti, l'ordinamento giuridico italiano ha introdotto la Legge Fortuna – Baslini, ovvero la n. 898- “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, elaborata da Loris
Fortuna e da Antonio Baslini. La strada per giungere a questo risultato è stata davvero molto lunga.
Il divorzio arrivò in Italia agli inizi del 1800 con Napoleone, che consentiva di sciogliere i
matrimoni civili. La Legge, poco sfruttata all'epoca, era davvero molto complicata nell'applicazione: i coniugi per separarsi avevano la necessità dell'approvazione dei genitori e dei nonni. Ci volle circa un secolo perché in Italia si rimettesse mano a questa norma.
Progetti per l'introduzione del divorzio in Italia furono presentati dai liberali fin dal 1878
con la proposta Morelli, seguita dai progetti di legge Villa (1882-1883), Villa – Zanardelli
(1882), per concludersi definitivamente con il progetto Zanardelli del 1901.
Nel 1902 il Governo di Giuseppe Zanardelli elaborò una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, di lesioni del codice, ma anche di condanne gravi.
Purtroppo non venne approvata e non si parlò più di questo tema per più di cinquant'anni.
L'Italia rimase molti anni senza una legislazione in materia.
Il divorzio era ammesso in quasi tutto il mondo civile. Era da sperare che venisse introdotto anche in Italia poiché l'opinione pubblica diventava ogni giorno più favorevole e due progetti per attuarlo, proposti dal Villa e dallo Zanardelli, ottennero già l'approvazione delle Commissioni parlamentari nominate ad esaminare quei progetti. I costumi nostri sarebbero senza dubbio migliorati ma rimase tutto come prima.
Loris Fortuna, deputato socialista, presenta il primo ottobre 1965 in Parlamento un
disegno di legge per l'istituzione del divorzio, più precisamente “Casi di scioglimento del
Matrimonio”. Nell'inizio della relazione alla Proposta di legge n. 2630 si legge:”
L'esigenza di una riforma dell'istituto matrimoniale, intesa a introdurre attenuazioni al principio della indissolubilità, non è cosa di oggi; essa veniva costantemente avvertita da legislatori, giuristi, scrittori e da uomini di governo prima ancora che lo Stato con il codice del 1865, sottrasse alla egemonia della chiesa cattolica la disciplina del matrimonio.
Ed è bene ricordare che dall'Unità d'Italia ad oggi sono state, al riguardo presentate al Parlamento ben 10 proposte di legge per lo scioglimento del matrimonio, di cui due di iniziativa governativa; nessuna però ha avuto utile esito”.
Ci avevano già provato i socialisti Renato Sansone e Giuliana Nenni, negli anni cinquanta, mettendo a punto una legge di “piccolo divorzio” per i casi estremi di ergastolani, malati di mente, scomparsi, divorziati all'estero. Nella presentazione del disegno di legge, Fortuna spiega la necessità della riforma con la condizione di isolamento in cui era venuto a trovarsi il diritto italiano, in questo istituto, rispetto agli ordinamenti stranieri, e con la considerazione che in quegli anni la media annua dei figli illegittimi è di circa ventiduemila, e la media annuale delle separazioni legali si aggira fra novemila e diecimila.
La legge sul divorzio permette di sciogliere, secondo le parole di Loris Fortuna, ciò che
“per ragione propria dei componenti è già virtualmente disciolto” e pertanto di porre
rimedio a una situazione di fatto già molto diffusa.
Il carattere popolare che andava assumendo la battaglia divorzista era testimoniato anche dal numero di messaggi (32.000 cartoline e 4.000 lettere) che Fortuna aveva ricevuto alla Camera tra l' Ottobre e il Marzo 1966 su iniziativa del settimanale “ABC”, e che furono presentati al Presidente dell'Assemblea in occasione del dibattito sulla giustizia.
Mentre il movimento cresceva, in Parlamento iniziavano le manovre diversive per non discutere la legge con la presentazione di una proposta di riforma del diritto di famiglia a firma del Ministro Reale repubblicano, in attesa del quale si sarebbe dovuto accantonare la proposta Fortuna.
E contemporaneamente, di fronte a un'opinione pubblica che si andava sempre più interessando alla questione, si muovevano le gerarchie cattoliche e lo stesso Pontefice Paolo VI che all'inizio del 1967 aveva pubblicamente espresso “sorpresa e dispiacere nei confronti del Parlamento che si era espresso favorevolmente sulla compatibilità del divorzio con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano”.
Di fronte agli indugi e alle reticenze dei partiti laici, che pure si erano tutti pronunciati in favore del divorzio ma non riuscivano a dare un seguito operativo alla scelta, la Lid nel congresso di Roma si apriva con l' interrogativo “Verso le liste divorziste alle elezioni?” proposto dal segretario della Lid (Lega Italiana per l'istituzione del divorzio) come arma di pressione verso i partiti. Dal Congresso uscì invece l' indicazione di appoggiare quei candidati che fossero impegnati a rappresentare il progetto divorzista nella nuova Legislatura. Così accadde che il 5 Giugno 1968, subito dopo la prova elettorale 70 parlamentari dei partiti laici, PCI, PSU, PSIUP, PRI, a eccezione dei liberali che
proposero il 7 Ottobre 1968 un loro progetto a firma di Antonio Baslini – presentarono un
disegno di legge unificato, ancora con primo firmatario Loris Fortuna, il primo della quinta
Legislatura Repubblicana.
Nell'Aprile 1969 il progetto di tutti i laici, ulteriormente unificato con quello presentato separatamente del liberale Antonio Baslini, fu discusso alla commissione giustizia della Camera dei Deputati per iniziare poi, alla fine di maggio, il dibattito generale in aula. Per la prima volta una proposta divorzista veniva affrontata a Montecitorio. L'avvenimento poteva essere considerato di portata storica, tanto più in presenza di una maggioranza relativa di Governo di osservanza cattolica.
Di fronte ai tentativi di ritardare la discussione Marco Pannella segretario della Lid (Lega italiana per l'introduzione del divorzio), iniziava assieme ad altri radicali lo sciopero della fame per la fissazione dei termini delle votazioni e il 29 Dicembre 1969 la Camera dei Deputati votava la Legge con 325 voti favorevoli e 283 contrari.
Dopo la votazione alla Camera dei Deputati, il buon esito finale della legge sul divorzio era tutt'altro che scontato. In Senato della Repubblica la maggioranza dei partiti divorzisti era molto più ristretta e con notevoli incerti. Tra i molti ostacoli che venivano continuamente posti, i democristiani sollevarono l' eccezione di incostituzionalità sull'estensione del divorzio ai matrimoni concordatari per bloccare la discussione e il Vaticano da parte sua, inviava una nota al Governo italiano per dichiarare che quel disegno di legge violava il Concordato.
Dal Settembre al Novembre 1970,il lungo e difficile iter legislativo del divorzio, sotto la pressione dell'opinione pubblica, arrivò in porto avendo ragione di tutti gli ostacoli che si frapponevano. Il 9 Ottobre 1970 la legge modificata da emendamenti contrattati dallo schieramento divorzista con la DC passava nel Senato della Repubblica.
Nella notte tra il 30 Novembre e il primo Dicembre 1970 la proposta di legge Fortuna – Baslini venne definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati con 319 voti favorevoli e 286 voti contrari, divenendo la Legge 898 che introduce nel nostro ordinamento giuridico il divorzio.
All'uscita da Montecitorio, l' onorevole Loris Fortuna venne portato in trionfo dai divorzisti, ma dopo quel risultato, per varare la legge, ci volle ancora un anno.
Loris Fortuna intuì lo straordinario cambiamento che stava avvenendo nel nostro Paese.
Un Paese nel quale la politica (intesa come classe dirigente) viveva come se l'Italia fosse ancora quella del dopoguerra, mentre una parte rilevante della società era già in linea con le grandi trasformazioni che stavano avvenendo nell'Europa. E quindi lui capì, ed era favorevolissimo, che era opportuno spingere nel suo Partito Socialista la componente liberale, la componente laica, favorevole alla modernizzazione e alla laicizzazione dei costumi del Paese.
Non fu facile, se pensiamo che persino nei movimenti giovanili della sinistra risentivano di
una tradizionale posizione che era più impegnata sui problemi della società economica,
addirittura con frange dichiaratamente anticapitalistiche.
Lui capì questo e fu importantissimo e fondamentale per la vittoria, sia parlamentare e
poi referendaria. Perché diede la possibilità a donne e uomini politicamente diversi di essere liberi dal legame di appartenenza e di costruire un elemento di mobilitazione di massa, che ha avuto poi anche la grande capacità di condizionare positivamente i lavori parlamentari.
L'approvazione del divorzio rappresentava un fatto pressoché unico nella storia dell'Italia
repubblicana per almeno due motivi. Perché la riforma era stata promossa attraverso una azione che si era configurata principalmente extraparlamentare, e perché per la prima volta la Democrazia Cristiana era stata battuta in Parlamento da una maggioranza che aveva unito nello stesso fronte tutti i partiti laici,dal PCI al PLI. Quel successo, ritenuto impensabile solo cinque anni prima, ebbe ripercussioni nelle vicende politiche italiane del successivo quinquennio.
Il Dicembre del 1970 è uno di quei momenti della storia d' Italia destinato ad esser ricordato per lungo tempo. Il Parlamento italiano, approvando una legge che regolamenta lo scioglimento del matrimonio introduce nel nostro Paese l'istituto del Divorzio. Si conclude così un lungo percorso di battaglie e rivendicazioni nelle piazze, nelle case e nelle aule dei Tribunali iniziato già alla fine dell'ottocento.
La storia ormai cinquantennale di questa legge si sovrappone a quella di un periodo che ha visto profondi cambiamenti sociali e politici nel nostro Paese. I legami familiari e i vincoli derivati dall'unione coniugale sono stati, e continuano ad essere un aspetto particolarmente sensibile e delicato che spesso si sovrappone a questioni religiose, di giustizia sociale e di uguaglianza di genere. Non a caso, infatti la legge sul divorzio, è stata spesso criticata, ripensata e aggiornata negli anni seguenti al fine di adeguare la legislazione ai rapidi cambiamenti sociali.
Nel 28 giugno del 1972 Loris Fortuna presentò una proposta di legge “Riforma del diritto di famiglia” che sulla scia dell'approvazione della legge del divorzio e della vittoria sul referendum che prevedeva la sua abrogazione, dopo un laborioso iter parlamentare il 19 maggio 1975, il Parlamento italiano approvò la legge 151 per la riforma del diritto di famiglia, con una larghissima maggioranza e la sola astensione del Movimento Sociale Italiano.
Cadde la patria potestà, passò la parità dei coniugi nella coppia e soprattutto sparì la discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del paese che riconobbe alla donna una condizione di completa parità con l'uomo, all'interno della famiglia, e garantisce la tutela giuridica dei cosiddetti “figli illegittimi”.
Senza il progresso civile che è stato iniziato con l'introduzione delle leggi volute da Fortuna, non ultima quella sul “nuovo Diritto di Famiglia”, molto più difficile sarebbe stato l'emergere di rapporti di uguaglianza, l'accesso consistente a tutte le professioni e l'affermarsi di una nuova dignità e libertà per la donna.
Loris Fortuna fu una particolare figura, spesso dimenticata del socialismo italiano. E' difficile infatti trovare una biografia che comprenda tutto ciò che ha rappresentato.
Dalla legge sul divorzio alle numerose battaglie per i diritti civili.
Andate su Google, e digitate Roma via Loris Fortuna. zero. Fate poi la prova con Milano, Torino, Napoli, Bologna….sempre zero. A Udine risulta un parco con il suo nome e recentemente gli Avvocati suoi colleghi, hanno ottenuto che venga intitolata a suo nome un'aula del Tribunale della città friulana.
Mi auguro che per il futuro avvenga quanto Il mio fraterno amico on Roberto Villetti ha scritto sull'Avanti!, in occasione della sua scomparsa, che: “Loris Fortuna è stata una personalità importante che sarà ricordata per la legge sul divorzio, che è stata una cosa veramente grande nella civilizzazione del nostro Paese e sarà ricordato anche quando altri, che hanno ben meritato per la Repubblica e ci appaiono più importanti, saranno dimenticati”.
*
GIOVANNI CREMA Sindaco di Belluno per un quadriennio con il Partito Socialista Italiano, diventa parlamentare dei Socialisti Italiani nel 1996 alla Camera dei deputati, dove guida la componente socialista nel gruppo misto anche dopo la trasformazione in SDI.
Durante la XIV legislatura è presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Nella XV legislatura è componente dell'Ufficio di Presidenza della Lega delle autonomie locali. Nel 2005 presenta la relazione parlamentare sul caso Antonveneta e le intercettazioni dei senatori[6]: si trattò della prima riflessione intorno ad una guarentigia "di difficile gestione (vista la natura di atti a sorpresa di queste misure)"[7], riflessione in buona parte confermata dalla successiva sentenza n. 390 del 2007 sulla Legge Boato. Nel 2024 abbandona il PSI per aderire al Movimento Socialista Liberale di Oreste Pastorelli.